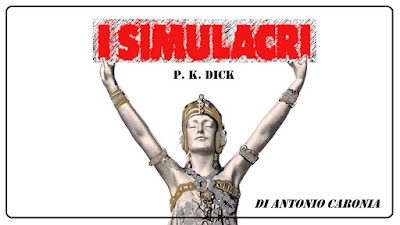|
| Libreria Utopia ottobre 2002 |
La prima conferenza
del ciclo ha avuto il suo esordio in un breve intervento semi-teatrale di un
giovane appassionato dickiano Nicola
Disilvestro che nelle sembianze mascherate di un inquietante Palmer
Eldritch (dal romanzo Le tre stimmate di Palmer Eldritch)
ha palesato tutto il disagio dell’adesione delle nuove generazioni al sofferto
mondo dickiano .
“L’uomo vuole
assomigliare a una macchina (…) Perché è un animale atterrito dalla scoperta di
non avere senso” ma neanche l’essere
parte di un ingranaggio, comprensibile e controllabile, può alleviare il nostro
terrore perché “l’umano è l’unica macchina conscia in un mare di macchine
inconsce… l’umano è l’unica macchina che soffre… la nostra situazione ormai si
può descrivere come quella di una vite che sente su di se, e lei sola lo sente,
il peso dell’intero macchinario …e piange…”
Saluto di Sergio
Fanucci, editore che sta pubblicando l’opera completa, con nuove
traduzioni, di Philip K. Dick.
Dall’intervento di Franco
Romanò: “l’opera di Dick , nel considerare il bene e il male nella
storia, assomiglia all’Apocalisse di Giovanni. Cosa vede Giovanni
nell’Apocalisse: vede che nella storia non c’è redenzione (vede che gli
eserciti di Dio si comportano come gli eserciti del demonio). Quindi la
redenzione non si da nella storia. Nella sua visione finale la città di Dio
scende dal cielo, come un’astronave, viene da altrove, non è nella storia, non
è possibile, non si da nella storia ma si da in un tempo in un luogo che è
fuori dalla storia. In Dick in un certo senso accade la stessa cosa. Non è che
il male vince. In Dick è presente la lotta tra il bene e il male ma anche il
bene diventa il suo contrario e viceversa. Cioè anche in Dick il bene usa
strumenti che lo rovesciano nel suo contrario, che diventano male. La causa che
ci sembra più buona travalica e diventa il suo opposto. In Dick non c’è
l’escatologia finale. Ma in un romanzo vedo una risposta. In Follia
per sette clan c’è un’escalation di guerre continue che ci conduce alla follia
dei nostri giorni. Quando finisce la guerra? Quando una coppia, un uomo e una
donna ritrovano la strada dell’amore. La guerra è iniziata per la disarmonia di
una coppia. Sembra una ingenuità americana. Dick in sostanza dice: l’energia
cosmica che governa i rapporti personali è la stessa che governa il mondo e le
guerre, quindi se l’armonia c’è da una parte c’è anche dall’altra e viceversa.
Ingenuo? Probabilmente si, ma vorrei ricordare che la civiltà occidentale nasce
da una guerra di cui non capiremo mai le ragioni solo storiche ed economiche
perché a un certo punto ci dobbiamo fermare di fronte al mistero di una donna
che ha lasciato un uomo, o che è stata rapita ed è finita in un territorio
straniero. La guerra di Troia nasce da questo.”
sabato 12 ottobre
Seconda conferenza:
“L’esegesi religiosa in Philip K. Dick”.
Carlo
Formenti: “ L’esegesi di Philip K. Dick è un’autoesegesi, cioè
un’esegesi della sua stessa opera riletta a posteriori come rivelazione
religiosa inconsapevole.” (…)
“La cosmologia della gnosi mette in piedi una costruzione
totalmente negativa e paranoide dell’universo e del mondo , per cui il mondo in
cui tutti noi viviamo è in realtà un mondo fasullo, creato da un cattivo
demiurgo, da una deiezione della divinità che si è persa per strada la sua purezza
originaria, che è progressivamente degradata e nella sua ultima incarnazione ha
creato la materia e il mondo come carcere per dei frammenti divini dispersi che
vengono incastonati nella materia. In sostanza noi, gli esseri umani, non
saremmo altro che delle faville di questa unità divina originariamente dispersa
nella materia, che rammemorano questa loro origine con fatica, per visioni
frammentarie, che aspirano disperatamente a ricomporsi in questa divinità
originaria che incarna invece, non tanto il bene cristiano, quanto la
completezza, la totalità.” (…)
“Dick, ancora prima di conoscere il pensiero gnostico,
condivideva con esso il pessimismo cosmico radicale, l’impossibilità di
arrivare a cogliere la
verità. Usciamo da una gabbia ma ne troviamo un’altra,
all’infinito, e questa è esattamente la simbologia della cosmologia gnostica.”
(…)
“Qual è la via di fuga, la via di salvezza per quanto
piccola, a cui Dick allude nei suoi ultimi romanzi? Ebbene, paradossalmente
dopo aver costruito un’intera visione, attraverso decine di romanzi e centinaia
di racconti, in cui l’agente di questo inganno gnostico , di questa
mistificazione della realtà è la tecnica, quindi gli androidi, quindi i media,
come elementi di mistificazione di massa ecc.; la possibile chiave di salvezza
che compare in quest’ultimo ciclo è in qualche modo la stessa tecnologia, che
però non è più vista come una serie di strumenti, oggetti, potenze o procedure
ecc., ma è vista come sfera complessiva della tecnica e in particolare della
tecnica di comunicazione. L’insieme dei prodotti della scienza, della
tecnologia, del pensiero umano, arrivati a un determinato livello di
complessità, in un qualche modo si autonomizzano, assumono una loro identità e
autoconsapevolezza , diventando una specie di supercoscienza planetaria. Un
cervello planetario in cui conversano come cellule di un sistema nervoso tutti
i cervelli dell’umanità.” (…)
“Una nuova frontiera che si apre, come nei sogni dei primi
colonizzatori che immaginavano l’America come l’Eden (…) Rinasce il sogno della rete dello cyber
spazio come nuovo Eden in cui andare a cercare una nuova possibile salvezza. E
Dick se l’è immaginata e inventata 30 anni prima che esistessero le tecnologie
che poi avrebbero sostenuto questo sogno.”
Fabrizio
Chiappetti:”Io credo che Dick sia il portatore di una sorta di
religiosità laica. Nel mercerismo di Ma gli androidi sognano le pecore
elettriche? Ne abbiamo la migliore esemplificazione.” (…)
“ C’è un voler essere insieme, un donare reciprocamente il
proprio niente all’altro; il proprio niente che, ha certo un’eco religiosa, ma
in questo passaggio del romanzo invece forse traspare proprio tutta l’umanità
possibile di questo dono. E allora traspare un modo di percepire, di pensare
l’umano che è affine a quello che il poeta John Donne diceva con un verso:
“nessun uomo è un’isola”. Nessuno è così povero da non poter essere nulla,
davvero nulla per l’altro e in questa compartecipazione forse sta la chiave, il
cuore di questa religiosità laica, profonda che si trova in diverse pagine di
Philip K. Dick.” (…)
“ Credo che in molte pagine di Dick emerga proprio questa
antropologia della relazione e che proprio in questa passione per l’umano , in
questa capacità di donarsi assolutamente anche nelle sconfitte, si trovi il nucleo
più interessante dell’opera di Dick; ricordando che ciò che resta sono le cose
donate, perché quello che si dona è qualcosa che si perde, scompare ma è anche
ciò che può resistere per sempre.”
sabato 19 ottobre
Terza conferenza:
“Leggere Dick oltre i generi”. Un esperimento: chiedere a un intellettuale, non
specialista di fantascienza, di leggere alcune opere di Dick e di confrontarsi
con un addetto ai lavori. In questo caso Edoarda Masi, una delle massime
esperte di cose cinesi in Italia e Carlo Pagetti, il massimo esperto di cose
dickiane in Italia.
Il risultato: un pro e un contro che propongono punti di
vista inediti e per nulla scontati.
Edoarda
Masi: “ Non condivido il modo di guardare il mondo di Dick. Non riesco a
capire dove c’è l’ironia e dove non c’è. La sua critica, così profonda e
disperata, della società in cui vive, critica lodevole e condivisibile, è però
una critica che si muove tutta dall’interno di quella società, senza sbocco,
quindi uno ha un senso di claustrofobia da un mondo da cui non si riesce a venire
fuori. Un mondo in cui, vedendo altri testi di Dick, può portare di fronte
all’uomo artificiale. A un certo momento se l’uomo artificiale è molto
perfezionato non si riesce più a capire il confine tra l’uomo reale e l’uomo
artificiale. Lo stesso robot è inconsapevole del suo essere robot. Che cosa è
questo? Questa è una simbologia. Questo uomo che non sa che cos’è in realtà
indica noi stessi come siamo diventati. E quindi indica l’incertezza
dell’identità che è nostra. E in questo senso Dick colpisce giusto. Però lui
non riesce a venirne fuori da questo. Non riesce ad avere, non dico una
speranza… perché poi al posto della speranza viene fuori, presi da altre
tradizioni, vengono fuori dei deliri mistici. E questo perché non c’è la via
d’uscita. Ora quando prima dicevo che lo vedevo vicino al decostruttivismo era
per questo motivo, una volta che si è presi dentro la trappola di una società
che ci si presenta come l’unica possibile e questa ci si presenta in termini
orribili, le scappatoie non ci sono più e la stessa critica si muove
all’interno di questa società. Non dico che oggi sia facile proporre delle
alternative, però, una vecchia europea di diversa formazione come me, sa o
pretende di sapere che tutto il nostro essere umano sta nella ricerca di queste
alternative e non soltanto nella distruzione disperata di quello che c’è,
perché è effettivamente orribile. E quindi l’uso migliore che riesco a fare
della letteratura di Dick è di documento. Di documento molto forte di quello
che è diventata la società americana prima e che sta diventando la società
mondiale sotto l’influsso della cultura americana. Allora come documento è
secondo me estremamente efficace, però soggettivamente l’autore non riesce a
portarmi fuori da questa gabbia, da questa scatola chiusa.
Carlo
Pagetti: “Io non credo che spetti agli scrittori di dare delle vie
d’uscita. Io credo che spetti agli scrittori di indicare i problemi, di dare
una visione critica della vita. Dopo di che aggiungo però che secondo me Dick
non è poi così pessimista come sembra; tanto è vero che è giusto, come ha fatto
la signora Masi,
collegarlo al postmodernismo, però alcuni studiosi marxisti americani, primo
fra tutti Fredric Jameson ha detto: attenzione Dick non è un postmoderno,
perché? Perché il postmoderno, almeno quello deteriore, costruisce sul nulla;
gioca col linguaggio, gioca con le parole e non ci dà nessun valore e invece
Dick ha dei valori etici che vengono fuori dalla sua narrativa.” (…)
“Da questa sorta di incubo e labirinto della storia
certamente non si esce, qualunque immagine possa emergere della storia certamente non c’è via d’uscita. E’ vero.
D’altra parte in questo, secondo me, Dick più che essere un postmoderno, l’ho
già detto altre volte facendo storcere il naso a qualcuno, è un vetero-modernista,
cioè è qualcuno che ha portato nella cultura di massa certe istanze del grande
modernismo dei primi decenni del secolo. Ha fatto questa geniale, almeno per
me, operazione di riprendere alcuni dei grandi temi, dei motivi del modernismo
e li ha riportati all’interno di un genere minore, come quello della
fantascienza.” (…)
“Dalla storia con la S maiuscola, nei romanzi di Dick, non
si esce quasi mai. C’è in qualche modo una via d’uscita? La via d’uscita di
Dick è una via, tipicamente americana. (…) Dick riteneva che quantunque la
storia fosse un incubo, un labirinto da cui non c’era via d’uscita, l’individuo
e soprattutto il piccolo individuo, l’individuo della strada, dominato,
terrorizzato, sfruttato, incapace di capire i grandi giochi di potere che passano
continuamente sopra la sua testa, tuttavia conservasse una sua dignità
personale, la quale poteva permettergli in qualche momento di sfuggire alla
devastazione. In un suo intervento Dick parla di questo individuo e dice: ci
sono certi momenti di scelta, quest’individuo può fare una scelta, non riesce a
rovesciare la visione del caos che domina il mondo, riesce a bloccarlo un
momento, con le sue scelte individuali, che sono scelte piccole, che non
modificano il quadro generale. Tuttavia questo individuo, che spesso compare in
un modo o nell’altro, nei suoi romanzi, ha questo potere di illuminare
momentaneamente una realtà, effettivamente disperata, tragica e di ridare senso
all’esperienza individuale.” (…)
“Esistono dei valori che perfino in un mondo totalmente
simulato e in qualche modo conquistato dalle macchine è possibile riconoscere
come autentici, e sono i valori della solidarietà, della dignità umana che non
può essere piegata neanche dagli inganni e dalle torture più crudeli. In questo
senso F. Jameson ha ragione, Dick non è un postmoderno.”
Edoarda
Masi: “Io prima ho dato oggettivamente luogo a un equivoco. Quando ho
detto: è un mondo claustrofobico senza uscita, non intendevo assolutamente
parlare di pessimismo. I più grandi autori, non solo del ‘900 ma anche
dell’’800, Dostoevskij, Kafka, Leopardi, sono forse degli ottimisti? Ma il
problema non è l’ottimismo o il pessimismo. Il problema, per me, non è il
rapporto tra l’ideologia e la scrittura, ma di quello che è interno alla
scrittura. Cioè dove non trovo come lettrice la via d’uscita e che quindi mi
rende questa lettura poco interessante… cioè non ho voglia di andare avanti
quando leggo queste cose è quando ci vorrebbero essere dei punti più lirici,
appunto più… e sono disastrosi perché sono appunto del cattivo misticismo,
intendo parlare di qualcosa che non è relativo ai contenuti cosiddetti ma è
interno alla scrittura. Cioè ad esempio, parlando dei grandi ci si capisce
meglio, se io legge Dostoevskij non è che quando sono alla fine dell’Idiota…,
si lui può avere la sua fede cristiana ecc. però in sostanza sono testi
fondamentalmente negativi, se uno guarda soltanto ai contenuti. Dov’è quello
che io dico che in loro c’è e c’è anche in autori minori ma che secondo me in
Dick non c’è. E’ quella, chiamiamola catarsi che è interna alla scrittura. Però
per dimostrare questo bisognerebbe fare tutta un’analisi dei testi che in
questa sede non si può fare. Quindi io posso soltanto dire quali sono le mie
impressioni di lettrice. (…) Quello che io chiamo claustrofobico è l’assenza
dell’elemento catarchico che è intimo alla scrittura artistica. C’è un saggio
molto bello di Franco Fortini su Leopardi dove parla della gioia che c’è nella
creazione di Leopardi e la gioia non è negli argomenti di cui Leopardi tratta
ma è nel fatto che riesce a trasformare in una forma letteraria, una forma di
poesia che a un certo momento è gioia per chi la crea e gioia per chi la legge;
ore questo, quando uno è disperato anche in quanto scrittore e non soltanto in
quanto essere umano, non viene fuori nella creazione. (…) Dick nell’insieme è
uno scrittore che non mi dice niente come scrittore, questo è il problema.
Allora io dico che come documento di un disperato e che però riesce in qualche
misura a rappresentare la disperazione collettiva, è reale, lo posso accettare.
Ma è molto limitato il limite entro cui come scrittore mi dice qualcosa. Questo
è il punto, e non il fatto che sia ottimista o pessimista, perché appunto
prendiamo Kafka... ma Kafka è uno scrittore che mentre lo leggi provi la gioia del leggere. E quindi
l'elemento catarchico è interno alla scrittura, non è un oggetto
ideologico."
sabato 26 ottobre
Quarta conferenza:
“Feticcio e mondo artificiale in P. K. Dick”.
Antonio
Caronia: (la conferenza integrale di Antonio Caronia
qui e
qui) “Nei suoi romanzi Dick appositamente ci lascia senza strumenti,
non ci da mai alcun indizio, (…) c’è una situazione di indicibilità analoga a
molti (lo dico in termini molto superficiali) dei problemi affrontati dai
logici matematici nel corso degli anni ’20 e ’30 e la loro scoperta che
esistevano alcuni problemi formalmente indecidibili. Come tutti sapete, Kurt
Godel su questa questione delle proposizioni formalmente indicibili ha scritto
un saggio nel '31 o ’32 che ha cambiato tutto il modo di vedere i fondamenti
della matematica prima di allora. Dick non ha letto Godel, però da un certo
punto di vista noi ci troviamo di fronte a un vacillare del concetto stesso di
realtà, della stabilità del reale. Però da un certo punto in poi della sua
vita, Dick ha cominciato a pensare di aver trovato una risposta. Ci sono state
le famose esperienze mistiche (del febbraio marzo del ’74) in cui lui venne
visitato da questa misteriosa entità aliena e lui rifletté per un sacco di
tempo su questa cosa e scrisse quella monumentale opera inedita, che sono le
otto mila pagine della esegesi; nella quale ad un certo punto si convince di
aver strappato in qualche maniera il velo di maja e di aver scoperto che noi
viviamo in una sorte di continuo presente. In pratica viviamo tutti ancora nel
70 dopo Cristo e che tutta la storia del mondo da quella data agli anni ’70 in
cui lui scriveva quelle cose) è un’orrenda finzione, è una maschera ecc. Tutti
gli ultimi anni della vita di Dick sono caratterizzati da questa cosa. Io sono
contrario a chiamarla svolta mistica perché io cito sempre a questo proposito
una bellissima pagina dell’esegesi, che Sutin dita distesamente, e a ragione,
nella sua biografia di Dick dal titolo
Divine
invasioni, in
cui Dick discute con Dio (scritta nelle ultime settimane prima della sua
morte). E c’è un bellissimo duello con Dio, un duello dialettico (che ricorda
molto i filosofi medioevali) nel quale Dick dubita e dice: non so se tu ci sei
davvero. Non so se tu sei davvero la causa delle cose che mi sono successe, io
dubito. E Dio dice: fai bene, dubita, prova, dai una certa spiegazione, vedrai
che a un certo punto troverai un assurdo, troverai una catena infinita,
troverai un regresso all’infinito. Cioè una delle figure cattive del
ragionamento tipiche della logica aristotelica e poi della logica scolastica. E
Dick fa questa cosa e dice allora infinito; come lui trova questo regresso
all’infinito Dio gli dice: ecco l’infinito, io sono l’infinito, vai avanti fai
un’altra ipotesi e lui fa queste ipotesi. E in questo c’è questa cosa in cui si
vede che Dick non ha mai abbandonato una fiducia nella ragione, nella forza
della ragione, pur con tutti i suoi fallimenti. Pur con tutti i limiti che lui
stesso riconosce. Ci sono delle cose che non si possono fare. Non ci possiamo
cavare dalla palude come il barone di Munchausen. tirandoci per il codino.
Abbiamo bisogno di un fondamento che vada da qualche altra parte. E questa cosa
è obbiettivamente moderna, non ha nulla del gioco, a volte un po’ cinico, anche
se molto interessante, con il quale i narratori postmoderni giocano con l’idea
di realtà.”
Giorgio
Concato: “Dick immagina che il mondo abbia avuto un altro corso,
rispetto a quello che conosciamo, a partire da un evento che è andato in un
altro modo, in genere dalla 2° guerra mondiale che è stata vinta da quegli
altri invece che da questi. E come sarebbero andate le cose allora?… E’ curioso
che attraverso questo espediente Dick
ricerchi come una dimensione ricorsiva della nostra realtà. Cioè il
possibile che sarebbe nato allora ci consente di leggere ricorsivamente
la realtà nostra di oggi ma vedendola come
dietro allo specchio. Andando dietro al feticcio e leggendo i meccanismi reali
che poi determinano queste illusioni che il feticcio instaura al centro della
vita collettiva. E’ un espediente in cui l’immaginazione assume una valenza
critica, cioè la metafora, il suo uso critico ci consente di leggere al di là.
Nella dimensione del simulacro, presente in
Ma gli androidi
sognano le pecore elettriche? La situazione cambia. Nel simulacro c’è
un’allucinazione collettiva (non più di un solo soggetto) che si è instaurata e
si è impossessata di tutti i soggetti di una società. (…) C’è un aspetto che
resiste, che non è del tutti colonizzabile dal simulacro; Dick vede questa
natura che resiste in questa capacità di interiorizzare i significati. Questa
riserva di senso che si può dare alla realtà, questa capacità di
simbolizzazione della realtà non è completamente esaurita; tanto è vero che
Mercer può esserci o non esserci a seconda di come uno riesce a dargli vita,
della finzione che riesce a dargli. La compassione è un altro elemento che
resiste, che è irriducibile perché anche per un rospo meccanico si può provare
compassione. E quindi anche nel mondo dei simulacri la compassione è un
elemento che non viene completamente colonizzato.”